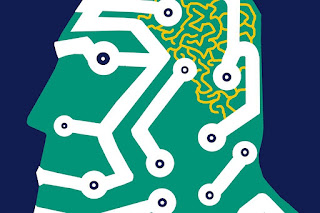Freud, l'intelligenza artificiale e noi. Alle radici dell'effetto «AIcebo»
L'Europa dell'Intelligenza artificiale, un gran bell'inizio
L'Unione Europea prova a dare alla tecnologia il posto che merita: a servizio. Perché l'AI non è Satana ma senza una direzione umana è un potere che fa e farà male. È il primo atto di una sfida che avrà eroi e morti, detrattori e nostalgici e a cui tutti siamo chiamati. Il punto chiave? Che una tale norma esista.
Il Parlamento europeo ha approvato la "posizione negoziale sulla legge sull'Intelligenza Artificiale" con 499 voti a favore, 28 contrari e 93 astensioni. Di qui partono ora i negoziati con il Consiglio e i colloqui con i singoli governi dell'Unione Europea per la stesura di un testo definitivo. Con questo atto politico così importante l’Europa si posiziona chiaramente nel mondo e nel panorama mondiale come un attore politico e culturale dai contorni e dalla volontà ben precisi. Le questioni economiche sottese all’intelligenza artificiale sono enormi e su queste pagine in diversi ne hanno trattato. Non mi soffermerò su questi temi, sebbene siano cruciali, e neppure desidero entrare nel dettaglio della norma approvata. Il punto che ritengo decisivo è il semplice fatto che tale norma esista e tale norma debba essere ritenuta il pensiero europeo su un tema così decisivo. Essa non contiene tutto quanto potremmo auspicare, ed è facile prevedere che i passaggi successivi e le successive interlocuzioni modificheranno alcuni elementi e forse qualche assetto.
Ma resterà un punto, il punto centrale. L’intelligenza artificiale non è un oggetto tecnico neutro. La tecnologia non è più solamente uno strumento la cui bontà o malevolezza dipende dall’uso che se ne fa e dalla volontà di un operatore. La macchina, che non pensa più di tanto, ma molto agisce accanto all’essere umano condizionandone il pensiero, ad esempio nel come e nel se farsi domande, ha bisogno di essere custodita ed educata nei suoi poteri.
Il modello della Ue
L’Europa, a differenza di altri sistemi di pensiero e potenze economiche mondiali, resta fedele ad una sua tradizione democratica e culturale: il vivere sociale è ordinato e soprattutto indirizzato attraverso delle regole condivise in modo democratico. Ben sappiamo che lo sviluppo giuridico ha tempi molto lenti rispetti allo sviluppo tecnologico e che frenare quest’ultimo a motivo della spesso poca efficienza del primo rappresenta una scelta ed un rischio economico. Ma nello stesso va considerato che la posta in gioco non sono solamente i dividendi, ma alcune dimensioni antropologiche fondamentali e gli assetti sociali su cui si fonda il mondo così come lo conosciamo.
L’intelligenza artificiale riporta al centro del dibattito culturale, politico ed economico il futuro umano. Il covid ha accelerato questo processo, ma è la tecnologia e soprattutto l’intelligenza artificiale a renderlo necessario ed ineludibile. Se gli orrori della guerra e dei campi di concentramento hanno in qualche modo sospeso il pensarci nel timore di scoprire quanto orrendo l’umano possa essere, abbiamo messo tra quel periodo ed il nostro tempo sufficiente per riprendere in mano la questione delle questioni: noi stessi, chi vogliamo e possiamo essere, non come singoli – su questo abbiamo ballato sui rispettivi ombelichi anche troppo – ma come umanità.
Non è una partita vinta
L’Europa dice a gran voce che nulla ha senso se la destinazione del nostro andare non è chi noi siamo. Il denaro ritorna ad essere mezzo, il profitto letteralmente utile, ma non esclusivo. Il Pil, in altri termini, è determinante ma per un fine che non sia se stesso. Non è una partita vinta, non è una sfida che si conclude. Essa inizia esattamente oggi ed avrà eroi e sconfitti, detrattori e nostalgici. Ma è una grande sfida a cui democraticamente siamo chiamati tutti. Vorrei citare una grande donna europea, spesso conosciuta più perché la moglie di un grande uomo europeo che per se stessa. Ma essa è e resta non solo la sua ispiratrice ma, soprattutto, una lucida ed illuminata intelligenza nella cultura del secolo scorso in tensione verso il nostro secolo, Raissa Maritain. In Le Prince de ce Monde, ella scrive: «Lucifero ha gettato su di noi la rete invisibile ma forte dell’illusione. Fa amare l’istante contro l’eternità, l’inquietudine contro la verità. Ci persuade che non possiamo amare la creatura che deificandola. Ci addormenta, ci fa sognare (interpreta i nostri sogni) ci fa operare. Allora lo spirito dell’uomo è portato su acque paludose. […] In verità sembra che tutto gli appartenga, e che sia necessario tutto strappargli. E tuttavia tutto gli è già stato strappato. Il mondo è salvato».
Era il 1932. L’intelligenza artificiale non è il male, non è Satana. Ma senza una direzione umana essa è un potere che fa e farà male, senza che vi sia il senso umano a bilanciare l’ubris che da essa promana i rischi che corriamo sono i medesimi del nucleare e del cambiamento climatico.
L’Europa lo sa, l’Europa lo dice, l’Europa strappa alla macchina un primato che non le conviene, senza distruggerla o umiliarla, semplicemente dandole il posto che merita. A servizio e non in grado di asservire. È una gran bella notizia. È un inizio.
La mala educazione di ChatGPT, tutta colpa dell'input che riceve
Scrive molto bene, ma di lei ultimamente scrivono in parecchi molto male: ChatGPT. Mi inserisco volentieri nel dibattito che anche su queste pagine digitali si è svolto per portare un ulteriore contributo. Già si sono sottolineate le questioni etiche, i rischi legati allo sconquasso che tali sistemi porteranno nel mondo del lavoro, alla necessaria riorganizzazione delle imprese sino ai timori legati all’uso improprio di tale tecnologia soprattutto da parte dei più fragili per età o per condizione sociale.
Mi pare che tutti i timori che possiamo legittimamente e coerentemente elencare possono essere per molti versi ricondotti ad un medesimo tema, così come eventuali soluzioni. Ritengo che un modo concludente di affrontare la questione non sia quello di determinare a tavolino e preventivamente degli stop predeterminati a questo tipo di tecnologia ed alle sue applicazioni. La questione deve invece essere ricondotta a monte per potere poi agire con maggiore consapevolezza a valle. Il punto di partenza è l’educazione, da leggersi sotto due profili che si integrano ed intersecano tra loro. Oggi la macchina non deve essere semplicemente addestrata. Quanto produce nasce da una lettura di dati giocoforza corrotti. Corrotti in senso tecnico e corrotti in senso etico. La macchina non ha capacità di discernimento e di senso, legge in modo computazionale, per quanto evoluto. Questo la porta a pensare ed agire in modo corrotto perché l’input che riceve è corrotto.
La necessità di un percorso educativo
Di qui la necessità che al semplice addestramento si approdi ad un percorso educativo. Se effettivamente essa si sta dimostrando capace di associazioni più complesse che non un sistema stocastico allora è necessario cominciare a pensare come bene educare la sua intelligenza profonda. Ciò non significa dare un’anima o una coscienza alla macchina, questo non sarebbe possibile, ma passare dall’addestramento all’educazione sì, ovvero una capacità di giudizio del dato usando il parametro etico come nuovo parametro di valutazione della performance della macchina. Per realizzare questo la direzione è quella, certamente giudicata scomoda in molti settori, di riprendere in mano la questione della verità ed implementarla nuovamente nel sistema semantico della macchina e forse non solo.
Non vi può essere esattezza e giustizia senza verità, e non è accettabile che il potere anche epistemico di tali macchine non sia guidato ab origine da tale criterio. La seconda educazione a cui dobbiamo tendere è quella dell’altro partner della macchina in questo tempo, l’essere umano. Le questioni sono particolarmente sofisticate e, dunque, parrebbe impossibile chiedere a chiunque di comprenderne la portata e di padroneggiare i sistemi. Per educazione però non intendo il conferimento a chiunque di capacità tecniche, ma la sapienza e l’informazione per chiunque di conoscere, a grandi ma decisive linee, di che cosa stiamo parlando, di come queste macchine funzionano, di che cosa in particolare ChatGPT è capace, di cosa non è capace, di che cosa è bene che non sia capace, cioè a che cosa sarebbe bene che non si applicasse. Il potere trasformativo di queste tecnologie è tale e tanto che è in gioco la democrazia e non solo nella società, pensare di poter trattare tutto questo come un tema esotico di cui solo alcuni possano e debbano occuparsi non è più tollerabile.
Educazione dunque, in tutti i sensi e latu sensu. Papa Benedetto XVI in tempi non certo sospetti, ma profetici, parlò di emergenza educativa e venne ingiustamente tacciato del consueto oscurantismo clericale che ciclicamente viene ripescato. Scriveva alla Diocesi di Roma il papa tedesco: “A differenza di quanto avviene in campo tecnico o economico, dove i progressi di oggi possono sommarsi a quelli del passato, nell'ambito della formazione e della crescita morale delle persone non esiste una simile possibilità di accumulazione, perché la libertà dell'uomo è sempre nuova e quindi ciascuna persona e ciascuna generazione deve prendere di nuovo, e in proprio, le sue decisioni. Anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta personale. Non possiamo pensare di fare a meno dell’educazione per la ragione di avere tra le mani uno strumento tecnico così potente e bello da farci toccare vette inesplorate, al contrario. Continua Benedetto: “Il rapporto educativo è però anzitutto l'incontro di due libertà e l'educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà”.
La tecnica ci libera da molte pastoie e fatiche, ma la libertà non è solamente liberazione da pesi, da vincoli, da fatiche. La libertà autentica è soprattutto la possibilità concreta di assumerci delle responsabilità. Come fare incontrare la libertà dei singoli dalla ricchezza inestimabile che viene dagli strumenti tecnici che l’essere umano è oggi in grado di creare ed operare? Benedetto risponde così: “anima dell'educazione, come dell'intera vita, può essere solo una speranza affidabile”.
Il fattore umano e il progresso
Riponiamo la speranza nel futuro nelle macchine, nel progresso tecnico e scientifico o, piuttosto nell’essere umano che di quel progresso è unico fattore e motore? La macchina presunta intelligente non ci faccia mai dimenticare che è l’essere umano l’origine e solo l’essere umano il fine. In una prospettiva di fede l’essere umano autentico capace di atti divini ed orientato ad essere pienamente umano e divino insieme. Sappiamo che è possibile educare l’umano. È possibile costruire macchine che incorporino dell’etica, che sia educate in tal senso? Solo rispondendo di sì è legittimo immettere nel sistema macchine, come Chatgtp che tanto incidono sull’etica e sulla vita. Altre strade sono semplicemente lesive della nostra dignità.
Qui il post originale
Trovare Cristo seguendo le stelle
CIELI SERENI (Edizioni San Paolo 2023, 159 pagine, euro 15) è un percorso straordinario: incrocia la luce che viene dal passato remoto della formazione cosmica e la luce che viene dal futuro, inaugurato dalla resurrezione di Cristo.
Nell’intreccio di queste luci con gioia e docilità avviene un incontro di brillante bellezza, di fulgore naturale e soprannaturale. Infatti cercare il colore nel nero del cielo sopra di noi, anzi trovarlo ancora di più tanto più è nero, restituisce luci e colori di cui il nostro cuore e la nostra vita hanno un bisogno assoluto.
Questo non è un libro scientifico, ma uno scienziato potrebbe scoprire quanto possa essere serio ciò che non è solo scienza. Questo non è un libro per astronomi, ma un astronomo potrebbe scoprire quanto possa essere preciso il suo rapporto con Dio.
Questo non è un libro per credenti, ma un credente potrebbe scoprire quanto possa essere bello fare un po’ di scienza dal proprio balcone. Questo insomma, non è un libro per qualcuno in particolare, forse per questo può essere un libro per chiunque. Chiunque voglia aprire la finestra di casa e guardare in su, o la finestra del proprio cuore e guardarci davvero dentro.
L’autore del libro è don Luca Peyron, sacerdote della Diocesi di Torino dal 2007 dopo un’esperienza accademica e professionale nell’ambito del diritto industriale. Laureato in giurisprudenza e licenziato in teologia pastorale, don Peyron vive il suo ministero soprattutto tra gli universitari e i giovani adulti andando in cerca di quei segni dei tempi che aiutino a ricucire lo strappo tra fede e scienza, tecnica ed esperienza di Cristo.
Parroco in città, attualmente è anche direttore della Pastorale universitaria diocesana e regionale. Ha fondato e coordina il Servizio per l’apostolato digitale che è uno dei primi servizi a livello globale della Chiesa cattolica con il compito di riflettere, progettare e agire rispetto alla cultura digitale in una prospettiva di fede. Insegna teologia in diversi atenei italiani. È Faculty Fellow del Centro Nexa del Politecnico di Torino e membro del Consiglio scientifico dello Humane Technology Lab dell’Università Cattolica di Milano. Collabora con alcune riviste e testate tra cui Avvenire e The Huffington Post, soprattutto rispetto ai temi della trasformazione digitale. Ha scritto saggi e libri di spiritualità.
STATI GENERALI MONDO DEL LAVORO: Il modello di change management in ottica di Welfare e Smart Working
mercoledì 28 settembre ore 10.00
Dal 27 al 29 Settembre 2022 si svolgerà la quarta edizione degli Stati Generali Mondo del Lavoro Italia. Tale evento, di risonanza nazionale, consentirà di realizzare un prezioso momento di incontro e di proficuo dialogo tra personalità delle istituzioni e del mondo del lavoro.
Rivolto principalmente ad aziende di settore, manager, OOSS, istituzioni, imprese, mondo della formazione, professionisti, ricercatori e studenti, il convegno favorirà un costruttivo confronto sui temi più rilevanti ed urgenti del dibattito contemporaneo sul mondo del lavoro: politiche attive, programmi di supporto alle aziende, innovazione, welfare e smartworking, nuove competenze e sostenibilità aziendale.
L’evento si svolgerà in presenza presso: Salone d'onore del Castello del Valentino, Viale Mattioli 39, Torino.
Ucraina. La realtà della guerra nell'era digitale e il bene di affidarsi a Maria
E internet e i sistemi per mantenere la connessione diventano salmerie, aiuti umanitari. L’oligarca americano Elon Musk invia in Ucraina tir di server, router e parabole per permettere la connessione al suo sistema satellitare Starlink che garantisce connessione efficiente in ogni angolo, o quasi, del pianeta, senza la tradizionale infrastruttura di server e cavi di terra che tutti usiamo e conosciamo. Nella metamorfosi digitale anche la guerra, così antica, così purtroppo parte del nostro essere umani, in qualche modo cambia.
La guerra è sempre tecnologica, a mani nude uccide Caino ma per ira o per raptus, quando la guerra è guerra ha sempre un gradiente tecnologico anche se la supremazia tecnologica non è detto che definisca gli esiti del conflitto, come ci hanno insegnato Vietnam o Afghanistan. Ma questa è una guerra in Occidente che ha tutti i tratti della trasformazione digitale e della cultura tecnica che la genera. Una condizione, quella digitale, sempre di più e del tutto immateriale e smaterializzata, che negli scenari evocati, desiderati o temuti del metaverso trasferisce in un ambiente digitale le nostre esperienze esistenziali.
Tuttavia in questa temperie culturale il corpo si riprende il suo spazio, anzi, la rappresentazione neorealista del corpo e delle macerie diventano, smaterializzati nella narrazione digitale, uno strumento essenziale di guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è passato da 500mila a 4milioni e mezzo di followers in meno di una settimana dall’inizio del conflitto, ha bisogno che le immagini dell’ospedale di Mariupol facciano il giro del mondo, chiama a raccolta attorno a sé i potenti della terra con hashtag e tweet e si lamenta, in diretta, dell’assenza di risposte, come è avvenuto con Mario Draghi. Le feluche hanno i loro tempi che il digitale macina e mastica a ritmi totalmente distopici rispetto a quel mondo. Perché Draghi, dopo quel tweet di Zelensky, si è prontamente connesso. La relazione tra materiale e immateriale diventa così tanto stretta e stringente, nel dramma della guerra, che la distinzione tra reale e virtuale tramonta forse per sempre.
Occhio non vede cuore non duole, recita il vecchio adagio che la guerra nella condizione digitale non solo non smentisce, piuttosto acuisce. Se si combatte sul campo ancora di più si combatte in rete con non minore violenza: ospedale pieno, ospedale vuoto, ospedale dei martiri, ospedale dei furbi che ne fanno un avamposto militare.
L’opinione pubblica russa, sino a che non è stata imbavagliata del tutto, si è spaccata in due. Giovani contro la guerra da una parte, adulti e anziani schierati con Putin contro i presunti fascisti che si nascondono in Ucraina. Le generazioni cresciute in un mondo globale sono state educate a guardare oltre lo schermo di casa, la visuale offerta dal governo, la narrazione di partito. E questa possibilità è nata grazie alla trasformazione digitale. Non basta, ma non è poco se pensiamo al futuro.
La strada è quella di continuare a educare i giovani a una identità globale, che non snaturi le istanze locali ma che faccia comprendere come esse possano darsi, come il bene del singolo, solo in un bene comune globale. Questo avviene in una condizione democratica, e la condizione democratica nasce quando il potere è nelle mani del popolo, nelle mani di tutti, quando il potere è suddiviso. La tecnologia digitale – pur in tutti i regimi di monopolio di questa prima fase di metamorfosi – restituisce molti poteri a tutti. Quello di informare, di informarsi, di condividere pensiero, di aggregare attorno a un pensiero. Strumenti che sono di pace perché disinnescano i poteri che generano le guerre.
Ma tutto questo può non essere sufficiente in assenza di una coscienza formata, senza una identità matura, senza le condizioni affinché vi siano identità, coscienza e formazione. Ecco allora che la consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore di Maria è una ulteriore parte della risposta. Non devozione usurata, come qualcuno sta scrivendo, ma profezia teologicamente e pedagogicamente strutturante. A maggior ragione nella condizione digitale. La Vergine Maria è segno e profezia di un cuore che, abitato da Dio, è capace di custodire una notizia e farne discernimento.
La tecnologia da sola non salva, ma unita a una coscienza che si apre alle profondità di Dio ha una potenza di bene, è capace di operare la pace, in modo formidabile. La virtualità se crea un ambiente che rallenta i tempi e dona il tempo di ascoltare le istanze profonde dell’umano, tenendole lontane da sirene e tempeste, restituisce capacità di senso e discernimento. Quante volte noi adulti abbiamo scosso la testa vedendo i giovani immersi in un cellulare o negli auricolari.
Forse molti non cercavano di evadere quanto piuttosto di trovare uno spazio di bellezza in mezzo agli spazi grigi che noi adulti abbiamo lasciato loro. La guerra è brutta, ma è una lente di ingrandimento su di una parte di quello che siamo, siamo diventati e potenzialmente possiamo diventare. In un mondo digitale.
Qui il post originale
Anche l’inquinamento luminoso è un pericolo, battiamolo con la tecnologia
Sono circa quattro mila gli oggetti celesti visibili a occhio nudo. Però dal deserto di Atacama in Cile. Dal mio balcone a Torino sono una manciata, così come lungo le coste della penisola, nelle città, ma anche nei paesini.
Per rivedere le stelle devo fare qualche chilometro in auto e poi altrettanti a piedi, per i monti, con i miei scout. Abbiamo rubato il fuoco agli dèi, ma ci siamo dimenticati che Prometeo lo ha fatto perché quel cielo lo interrogava, lo spingeva ad andare oltre.
Più volte abbiamo appuntato su questa nostra agenda digitale appuntamenti con la storia: uno di questi appuntamenti con le tecnologie emergenti riguarda il cielo. Infatti, il progresso non è automaticamente sviluppo e per mettere l’uomo al centro dobbiamo aver ben presente come si traguarda un centro e chi l’essere umano sia nel profondo.
Il Cielo nelle Scritture
E il cielo ci riguarda da vicino proprio in questi temi. La Scrittura ha sul tema pagine tanto liriche quanto vere e sono quelle che Paolo VI consegnò agli astronauti dell’Apollo 13. È il salmo 8 che vale la pena rileggere in parte insieme: “O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi? Eppure, l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna; Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra”.
Affinché l’essere umano sia davvero e pienamente sé stesso deve mantenere quell’umiltà che gli permette di essere generativo: come è la terra, l’humus che è la radice semantica di umiltà. In questa prospettiva il lenzuolo di stelle che ci sovrasta non è decorativo, ma è strumento di ispirazione e di senso, rimanda al molto già fatto ed al moltissimo che ancora è da fare.
La vera innovazione, la storia lo racconta, non nasce nei laboratori, nasce quando l’essere umano esercita con pienezza la sua innata capacità di andare oltre, di trascendere e non semplicemente correlare, di immaginare e non solo contare una serie data per quanto immensa. Non è poetica o semiotica, è storia, semplicemente storia. Poi viene il laboratorio, essenziale, decisivo. Ma mai sufficiente. Per andare oltre abbiamo bisogno di ispirazione, di motori di senso che non possono essere semplicemente i bilanci o gli encomi accademici. Per l’oltre ci vanno spazi che siano Oltre.
Di qui il firmamento, le stelle. Quei puntini che mano a mano si palesano alle nostre pupille bucando il nero del cielo e – fotone dopo fotone – ci parlano di altri mondi, di altre storie, ancora da scoprire, comprendere, abbracciare. Sempre Paolo VI lo ricordò la domenica successiva allo sbarco, il 13 luglio del 1969 dicendo: “L’uomo, questa creatura di Dio, ancora più della luna misteriosa, al centro di questa impresa, ci si rivela. Ci si rivela gigante. Ci si rivela divino, non in sé, ma nel suo principio e nel suo destino. Onore all’uomo, onore alla sua dignità, al suo spirito, alla sua vita”.
L’inquinamento luminoso
Come dunque rendere giustizia a Leopardi, Dante, Pascoli anche nelle nostre città e paesi e non solo in quota? L’inquinamento luminoso è uno dei tanti compromessi che la modernità ci ha costretti a fare: sicurezza, sviluppo culturale, turistico e ritmi sociali che girano su tutto l’orologio. Così come abbiamo sviluppato una coscienza critica su altre forme di inquinamento, è importante averne una anche su quello luminoso che minaccia non solo i cieli stellati, ma anche i nostri ritmi biologici. Da questo punto di vista la transizione digitale ci offre strumenti tecnici nuovi che possono aiutarci a spegnere le luci inutili, ad orientare quelle che grossolanamente sparacchiamo a destra ed a manca calibrando costi e benefici con maggiore attenzione e cura. Viviamo un tempo di incertezze radicali ed è illusorio pensare che siano gli algoritmi e fornircene di nuove. È vero invece che fioche luci del cielo notturno ci restituiscono il valore inestimabile di questo piccolo mondo che abitiamo, di coloro che ci abitano accanto, delle sfide che ognuna di quelle luci di fatto rappresenta.
La rivoluzione digitale ci ha regalato una nuova consapevolezza: non esiste un modo tecnico dato, ma un mondo tecnico in divenire di cui ognuno è parte non sostituibile. Nel digitale non esiste la massa, esiste il singolo con le proprie scelte e decisioni, ognuna delle quali nelle connessioni che ci legano al corpus sociale, ha ripercussioni importanti. Dal sensore nelle scale di un condominio ai pali della luce stradale, passando anche semplicemente a luci che tendono al rosso e che ugualmente danno determinate garanzie, ma non chiudono le nostre pupille, molto si può fare ed ancora di più sarà fatto costituendo insieme una cultura condivisa ed attenta su questi temi.
Edgard Morin ci ha insegnato (Il metodo.1. La natura della natura, Milano 2001) che la macchina può battere i viventi seconda la quantità, ma il vivente, rispetto all’ artificiale, ha proprietà rigenerativa nonché riparativa: anche la macchina più perfetta, posta in condizioni sfavorevoli non programmate, non è in grado di ripararsi: una macchina rotta è un semplice ammasso di materiale. La macchina non riparerà il mondo, ma noi sì. Usando meglio le macchine. Abbiamo 4.000 motivi per lavorarci, 40.000 se ci regaliamo un piccolo telescopio. Sono molti di più dei sogni che abitualmente facciamo ad occhi aperti.
Qui il post originale
Una riflessione sulla via italiana all'intelligenza artificiale
L’anno appena trascorso ha visto diverse importanti novità normative che hanno riguardato l’intelligenza artificiale. Ad aprile è iniziato l’iter dell’Artificial intelligence act, il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale che sarà affrontato nella plenaria del Parlamento europeo il prossimo autunno. Lo scorso 24 novembre poi è stata la volta della strategia nazionale italiana, un documento che ha visto la luce dopo un sofferto iter di tre lunghi anni, due stop&go e un cambio di squadra.
In Italia il dibattito sull’ecosistema dell’intelligenza artificiale risente di quelle che sono le caratteristiche per certi versi tipiche del nostro Paese. Abbiamo difficoltà a “fare sistema”, ovvero favorire lo scambio di idee ed esperienze fra i diversi settori e livelli produttivi, mancano finanziamenti seri e il nostro fiore all’occhiello, la rete accademica, forma bravi giovani che puntualmente vengono attratti da aziende estere, con stipendi iniziali che qui potrebbero ottenere solo dopo quindici anni di carriera.
Come ecosistema Italia abbiamo qualche rara qualità e molti difetti, che però con tenacia e perseveranza qualcuno cerca di correggere. Anche da qui è nata la volontà di cercare un filo conduttore per capire cosa dobbiamo fare per migliorare l’ecosistema di intelligenza artificiale nel nostro Paese. Dieci esperti italiani, provenienti da svariati settori e con alle spalle esperienze anche molto diverse, mostrano la strada per migliorare l’approccio all’AI in Italia. I loro consigli sono stati raccolti da una pubblicazione digitale, scaricabile gratuitamente, intitolata Intelligenza artificiale. Idee e proposte per l’ecosistema italiano.
Qui per scaricare il documento
I macro temi
Nei pareri degli esperti emergono temi comuni e condivisi, come la necessità di mantenere sempre l’essere umano al centro, proteggendo i soggetti vulnerabili dalla rapida evoluzione della tecnologia, oltre che l’esigenza di adottare subito un approccio multi-disciplinare e multi-stakeholder per consentire a tutti di partecipare allo sviluppo delle regole per l’AI.
Di centralità dell’essere umano parlano Viola Schiaffonati, docente associata di Logica e filosofia della Scienza al Politecnico di Milano, che sprona ad adottare una attitudine critica nei confronti del progresso in modo da mettere in luce la co-evoluzione della tecnologia e della società; don Luca Peyron, coordinatore dell’Apostolato digitale della Chiesa cattolica, che chiede tecnologie che non solo abilitino l’umano, ma che umanizzino le sue abilità; e Fabio Ferrari, fondatore della società Ammagamma, per cui il ruolo dell'uomo è centrale per indirizzare l’AI verso uno sviluppo positivo e non ambiguo.
Ma la centralità dell’essere umano va di pari passo con la responsabilità di chi crea algoritmi, che secondo Federico Cabitza, professore associato di Informatica all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dovrebbero essere certificati e conformi a standard specifici per essere non solo accurati, ma anche robusti e utili allo scopo. Di responsabilità parla anche Gianclaudio Malgieri, professore associato di Diritto e Tecnologia presso la Edhec Business School di Lille, secondo cui la grande sfida è bilanciare la protezione dei diritti individuali - e collettivi - con la spinta all’innovazione e alla competitività, sottolineando anche in questo caso che i sistemi AI dovrebbero essere non solo accurati e spiegabili, ma anche giustificabili e affidabili.
Il rischio è quello di creare degli “emarginati digitali”, i nuovi poveri del futuro, come avverte Emanuela Girardi, founder e presidente dell'associazione Pop AI, secondo cui l’Italia ancora non ha un piano per portare le nuove competenze nella società civile, cosa che potrebbe chiudere le porte del mondo del lavoro e della nuova società digitale a molti cittadini. Servirebbe nel governo un dipartimento per l’AI, conclude la Girardi, suggerendo un tema che ritroviamo anche nell’intervento di Stefano Quintarelli, imprenditore seriale ed ex deputato nella XVII legislatura, che chiede un aumento di consapevolezza da parte dei nostri decisori, pubblici e privati, affinché accompagnino la diffusione dell’intelligenza artificiale facendo in modo che sia compresa dalle persone, curandone la formazione.
L’AI, per usare le parole di Quintarelli, è una grande opportunità per il sistema produttivo italiano, un pensiero condiviso anche da autorevoli esponenti del mondo accademico come Nicola Gatti, professore in Ingegneria informatica al Politecnico di Milano, che sogna un’Italia dove sia consuetudine che il mondo delle imprese e il mondo della ricerca scientifica lavorino assieme per fare innovazione, e da Roberto Navigli, professore ordinario presso il Diag dell'Università di Roma "La Sapienza”, che chiede un avvicinamento fra il mondo dell’università e quello dell’industria, ancora troppo distanti, per generare sinergie fra ricerca e imprenditorialità. È così, spiega Navigli, che si apre la strada a startup universitarie ad alto potenziale di successo, vere punte di diamante dell'innovazione e della tecnologia made in Italy.
Delle eccellenze del nostro Paese parla anche Francesca Rossi, Global Leader Ibm sull'Etica dell'intelligenza artificiale nonché futuro presidente dell'Association for the Advancement of Artificial Intelligence (Aaai). Eccellenze che contribuiscono al nostro ecosistema, che a sua volta deve però essere supportato adeguatamente affinché la traiettoria che prenderà lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sia positiva per la società. L’acquisizione di competenze multi-disciplinari e l’approccio multi-stakeholder sono due temi cari a Francesca Rossi, come a molti altri esperti intervenuti, poiché necessari per consentire a tutti gli attori dell’ecosistema di intelligenza artificiale di essere ascoltati e di poter contribuire.
Esseri umani saldamente al centro dello sviluppo tecnologico, responsabilità dei produttori, protezione dei soggetti vulnerabili, collaborazione fra accademia e industria, certificazioni vere e non di facciata, serie valutazioni degli impatti sulla società, attenzione da parte di chi governa e tanta, tanta compartecipazione da parte di tutti. Sono questi i temi che gli esperti di AI hanno scelto per costruire un ecosistema che sia utile, produttivo e che protegga la dignità dell’essere umano. Affinché non siano in pochi a decidere quali traiettorie prenderà lo sviluppo dell’AI, bensì una platea estesa a tutti coloro che possono contribuire, qualsiasi formazione essi abbiano, perché l’intelligenza artificiale è un futuro che riguarda tutti.
Qui il post originale
Tra Betlemme ed Erode suggestioni tecno-teologiche per il nostro Natale
Il Natale di Gesù Cristo secondo la carne è, teologicamente, uno snodo decisivo per il contributo che il fatto credente può dare al tempo che viviamo, alla condizione digitale in cui siamo immersi, alle grandi questioni sul governo della rivoluzione digitale.
Credenti o meno, la parabola storica di Gesù Cristo rappresenta culturalmente un codice con cui leggere ogni contemporaneità. Evidenzia i tratti dell’umano che restano inalterati nel tempo e nello spazio, quei tratti comuni in cui è possibile la comunione, soprattutto in tempi di frattura e di cambiamento d’epoca come quello che viviamo. In questo spazio limitato mi siano consentiti due esempi concreti, ovviamente natalizi.La tecnologia della mangiatoia
Partiamo da quella mangiatoia così iconica in cui il Dio bambino viene deposto. Tecnologia semplice e contadina, ma pur sempre tecnologia utile alla nostra riflessione.
Una tecnologia plurale: la mangiatoia non è una ciotola.
La mangiatoia è per più di uno, per molti, per i molti. Spiritualmente per tutti coloro che vogliono avvicinarsi, umanamente per tutti coloro che vivono, studiano e lavorano affinché la tecnologia di base, vitale, sia per tutti e accessibile a tutti.
Il Dio che si rivela in Gesù Cristo non è un dio delle esclusive, ma dell’inclusione, dei tutti e mai dei pochi. Il fatto che si dia e si offra al mondo, attraverso una tecnologia plurale è la cifra teologica di una scelta politica ed economica che possiamo culturalmente promuovere e condividere.
La tecnologia di base, quella che custodisce la vita, quella che si prende cura di essa da subito, a maggior ragione se vita fragile ed inerme – quale la vita di un neonato – non può che essere commons, garantita come diritto umano. Che sia un vaccino o la connessione alla rete, gli strumenti di base per l’educazione e la scolarizzazione, oppure quei saperi necessari per accedere alla cittadinanza digitale dei paesi sviluppati, poco cambia.
La mangiatoia di Betlemme non è una invenzione della devozione, ma un dato della Scrittura preciso e chiaro. L’albergo non disponibile, la tecnologia di chi se la può permettere, ha nella storia della salvezza, una alternativa minima, un supporto vitale garantito dalla Provvidenza divina in un regime di solidarietà e sussidiarietà teologica che non deve mancare nello stato di diritto in cui viviamo. Non certo demandando al buon cuore di alcuni o al volontariato etico di altri.
La tecnologia del castello di Erode
Il secondo punto che vorrei sottolineare è la carne di quel bambino che per i cristiani è anche la carne di Dio. Erode ne ebbe paura e scelse di non muoversi dalle mura in cui era trincerato. La tecnologia del suo castello lo teneva al riparo dalla vita in una bolla inautentica. Manda i magi venuti dell’oriente per capire, per considerare, per scegliere. Per vedere. Quel bambino così particolare fu visitato, di persona, da molti. Ancora una volta, da una rappresentanza dei tutti. A cominciare dagli ultimi, i pastori, per arrivare ai primi, i magi appunto. Videro, credettero. Incontrarono.
Erode no, non vide, tantomeno credette, non incontrò. E scelse di uccidere, per paura. Il sangue innocente che fece versare nacque tutto dalla scelta di chiudersi nella sua tecnologia, gabbia di paure, al posto di vedere carne che incontra carne, quel bambino.
Questo è il secondo punto da sottolineare: la tecnologia che ci sostituisce per paura che l’incontro, la carne, ci faccia del male, non sia all’altezza, non sia sufficiente, ci metta in crisi.
La tecnologia che ci toglie la responsabilità dell’altro, del terremoto che potrebbe essere incontrarlo faccia a faccia, non è tecnologia buona,. Non è tecnologia auspicabile.
L’intelligenza artificiale che ci esonera dall’essere liberi, dall’essere responsabili, dall’essere presenti là dove esserlo ci umanizzerebbe, non è buona intelligenza artificiale. Non è intelligenza artificiale antropica, umanamente centrata così come, per esempio, chiede l’Unione Europea e auspicano le linee guida del Governo recentemente rilasciate.
Sono suggestioni tecno-teologiche dal Natale di Gesù, spero utili per continuare il nostro viaggio nella storia.
Qui il post originale
L. Peyron, La redenzione della carne in tempo di pandemia. Luoghi, persone e prossimità al tempo del coronavirus
Lessico di etica pubblica», 1 (2021) – ISSN 2039-2206
Abstract
Il Covid-19 ha imposto modifiche radicali cambiandoci tanto come individui quanto come società. La necessità di distanziamento fisico e l’assenza di scambio concreto hanno reso il digitale uno strumento ancor più presente nella nostra quotidianità, fino a trasformarlo in un’ancora di salvezza sociale e financo religiosa, privando però la comunità di uno dei tratti culturali che la caratterizzano: la corporeità. Questo contributo intende sostenere la correlazione tra la prospettiva del bene comune ed il bene della corporeità usando la liturgia cattolica come campo di indagine e rappresentazione della società in tempo di pandemia.Abstract (english)
Covid-19 radically changed the way we live, both as individuals and as a society. The request for social distancing and the absence of a concrete human exchange made the digital experience even more important in our lives until it becomes a focal point for social proximity, depriving the community of one of its central cultural traits: corporeality. This paper aims to support the existing relationship between the common good and corporeality, analyzing the catholic liturgical practice. This environment points out the importance of an actual society that prioritizes the human being rather than technological advancement. It emphasizes that we can restore the original sense of the common good only if we rediscover our sense of closeness, preventing the machine from turning into a tool designed to solve any possible social lack.Siri, Alexa e altri. Perché l'intelligenza artificiale può far dimenticare chi siamo
L’impiego diffuso dell’AI rischia col tempo di portarci a considerare gli umani come fossero macchine o le macchine quali titolari di dignità e diritti come gli umani
Non è così intelligente come sembra, ma certamente è più furba. Di lei si fidano tutti, anche e soprattutto quelli che solo vagamente sanno come funzioni. Un successo eclatante considerando che ha così pochi anni di vita, ed è in continua ascesa. I giovani la adorano, gli anziani la temono, gli adulti l’adulano. E non esiste. È solo un concetto dal perimetro piuttosto liquido, anche se abbiamo preso l’abitudine di darle dei nomi: Gpt3, Dabus, Siri, Alexa. L’intelligenza artificiale non esiste, o forse esiste troppo e dove non dovrebbe. Tra tutte le tecnologie emergenti è la regina, con numeri da capogiro, investimenti massicci, risultati sulle pagine dei giornali. E non esiste. Lo ripeto, come un mantra, l’AI (Artificial Intelligence) non esiste. Materialmente sono innumerevoli sistemi matematici con infinite variabili, tante quante le sue concrete applicazioni, o quasi. Righe di parole e numeri a cui noi colleghiamo ogni giorno sempre di più la nostra esistenza. Ne parliamo e scriviamo come fosse una entità indipendente, come se avesse vita propria, come se si potesse muovere e sviluppare come un organismo vivente, come se avesse un pensiero autonomo, come se avesse propri piano di sviluppo. O di conquista. Ma non esiste.
Feuerbach scrisse tentando di dimostrare, con un certo successo di pubblico, che Dio non esiste, che è semplicemente una proiezione dei nostri desideri e delle nostre paure. Oggi si potrebbe discutere con lui se non sia il caso di applicare tutto il suo sistema non tanto all’Onnipotente classico, quanto piuttosto all’onnipotente della condizione digitale, l’Intelligenza Artificiale. Non ne sto parlando male, visto che ne potrei parlare più o meno come potrei fare insultando lo spigolo del mobile in cui ho maldestramente infilato il mignolo del piede sinistro. Sì, perché l’intelligenza artificiale non esiste. Ma non ce ne siamo ancora accorti ed invece dovremmo. Per il bene di tutti noi. L’AI è uno strumento, non neutrale, come siamo venuti dicendo su queste pagine rispetto a tutte le tecnologie emergenti. È uno strumento complesso, ma un po’ meno di quanto la nostra immaginazione ci restituisce. È uno strumento estremamente utile che ci permette di vivere molto meglio, con meno preoccupazioni, ansie o paure.
Come i combustibili fossili della rivoluzione industriale, l’AI porta benessere a tutti, pur senza generare maggiore giustizia, ma generando certamente maggiore ricchezza complessiva e quindi con qualche briciola anche per gli ultimi. Sin qui oserei dire tutto bene. Ma come i combustibili fossili l’AI ha un rovescio della medaglia. Usando petrolio e carbone in modo massiccio abbiamo avvelenato il pianeta. Usando l’AI in modo massiccio rischiamo di avvelenare quanto abbiamo di più prezioso, forse più prezioso del pianeta stesso. L’umano. Niente film di fantascienza, né tentazioni luddiste. Usiamo l’intelligenza artificiale il più possibile e nei domini che più riteniamo utili e vantaggiosi. Ma usiamola cercando sempre di più e sempre meglio di darle una formalizzazione eticamente sostenibile e guarendo le falle che la fanno operare commettendo ingiustizie, azioni razziste, sessiste e via di nefandezze discorrendo. Ma teniamo presente sempre che essa non esiste e non deve esistere. Ma è tempo che mi spieghi: l’AI culturalmente ha assunto una sua identità e quasi personalità, è diventata un oggetto sociale con cui si interloquisce e, soprattutto, che consideriamo una di noi. Qui sta la questione, squisitamente culturale, ed incredibilmente tossica. Se consideriamo l’intelligenza artificiale un ente a sé, una nuova forma di personalità che si affianca a quella giuridica e umana, rischiamo di violentare in modo irreparabile la nostra dignità, che è tutto quello che abbiamo.
Creare un nuovo dio rende l’essere umano schiavo. Sempre. E lo stiamo facendo: i giovani del World Economic Forum hanno dichiarato che preferiscono essere governati da un’AI che dalla politica attuale; l’Ufficio Brevetti del Sud Africa ha concesso che un brevetto avesse per titolare dell’invenzione un’AI. Due notizie che si sommano alle molte che evidenziano una direzione di pensiero tanto spensierata quanto sconsiderata. Se infatti le multinazionali sono e saranno spesso oggetti degli strali della società o di una sua parte, chiunque sa che si tratta di una finzione giuridica necessaria per tenere in piedi un certo sistema economico. Nessuno pensa di poter interloquire con una Spa, né di sposarla, se non in modo metaforico, ma nella consapevolezza della metafora. Con l’intelligenza artificiale, sempre più antropomorfa, sempre più capace di imitare l’intelligenza autentica, sempre più consistente nell’interpellarci su cosa davvero possiamo o non possiamo considerare intelligenza, sta avvenendo qualche cosa di differente. Stiamo abdicando. Non le funzioni pratiche, ma l’essenza concreta di quello che siamo.
Per molto meno di un piatto di lenticchie. L’AI fatta persona veicola con forza nel nostro immaginario, nella cultura popolare e dunque nelle nostre scelte singole e sociali, due concetti devastanti. Il primo che l’essere umano sia sostanzialmente una macchina, e come tale funzioni, possa essere montato, smontato, sostituito, venduto, comprato. In tutto o in parte. Il secondo è speculare: la macchina è un uomo. Con pari dignità, autonomia, sensibilità, diritti. Ma la storia ci ha insegnato che l’essere umano può sopravvivere a sé stesso, al suo limite, al suo peccato, solamente se conserva la sacralità della sua intangibile dignità. La tecnologia, che è fatta per superare ogni limite e non avere limiti, per non soccombere a sé stessa ha bisogno di essere arginata in ciò che può fare, soprattutto in ciò che deve fare. Tale argine non è tecnico o scientifico ma esclusivamente culturale. Se togliamo gli argini che cosa ci resta e, soprattutto, cosa può accadere? Se la platea dei diritti si amplia alle cose, se la sacralità della persona si applica agli oggetti, per quanto senzienti e sofisticati, cadiamo nell’idolatria. Che non sta a presidio di Dio che, geloso, si vede messo da parte. Essa è a presidio dell’essere umano, che pensa di potersi salvare con un vitello d’oro. Invece solo mettendosi in ascolto di una paternità che consegna le dieci parole è possibile l’unico dialogo fecondo e fondativo, quello con il Creatore e di lì con le altre creature.
Non sono in grado di prevedere se una AI con dignità e poteri umani voglia decidere un giorno di sterminarci. Anche se certi film più che spaventarci di tale possibile futuro, in realtà lo hanno reso così ridicolo da renderlo possibile, togliendoci ogni difesa. Sono invece convito, con buone ragioni anche biblicamente fondate, che dare all’AI dignità umana renda l’umano ancora più marginale e residuale, soprattutto l’umano fragile, incapace di competere con la macchina, povero, quello in cui si è incarnato Gesù tanto per capirci. Un’AI con dignità umana ci porta a pensare, e dunque scegliere, di essere macchine rinunciando ad essere umani. Il cavallo di Nerone non fu un buon senatore, mentre ottimi cavalli avrebbero permesso di giungere in senato a senatori provenienti da ogni parte dell’impero. L’AI non esiste. Mentre esistono diversi miliardi di persone sulla terra che grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale, finalmente, potrebbero essere ascoltati, potrebbero mettere a frutto i loro talenti, concorrere al bene comune, vivere e morire in relazione. Credere. All’essere umano la dignità, all’AI il lavoro sporco. Senza rimpianti, anche perché lei, che è sporco, neppure lo sa.
Qui il post originale
Professione “antronomo”: una nuova figura per mettere l’umano al centro dell’intelligenza artificiale
L’Europa ha una sua via all’intelligenza artificiale, o perlomeno ci prova. Il dibattito su questo tema ha trovato dal rilascio della proposta della Commissione Europea anche su questo portale diversi interessanti contributi. Al di là delle posizioni differenti, più critiche o più entusiaste, è piuttosto evidente che la via europea, antropocentrica, suppone e presuppone nuove e diverse strategie e organizzazioni non tanto o non solo della ricerca, ma soprattutto dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e de relato, in qualche modo, anche di tutte le altre tecnologie emergenti.
La via europea all’AI
L’approccio adottato, basato su diversi livelli di rischio, fa presupporre un futuro sistema di certificazioni di tali rischi effettivi e una filiera di imputazione di responsabilità a livello nazionale e internazionale con relativi ruoli, obblighi e poteri di enti pubblici e privati. La proposta di regolamento richiede una dichiarazione di conformità e la marcatura CE prima del lanciare un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio, nonché un monitoraggio a lungo termine fino alla fine del ciclo di vita del sistema.
Chi, concretamente, si occuperà di queste procedure?
La proposta della Commissione, che è l’ultimo atto in ordine di tempo di una catena che man mano sta disegnando questo settore, rappresenta una novazione anche rispetto alla necessità di nuove figure professionali, di nuove ibridazioni di saperi e, dunque, di nuove filiere formative ed educative del tutto peculiari. Il mondo che ci apprestiamo a vivere, digitale, sarà ed è già diverso da quello che abbiamo conosciuto, non torneremo al noto di prima. Non sarà un futuro necessariamente peggiore o migliore, sarà certamente diverso. Soprattutto in un aspetto: la gran parte delle relazioni – sociali o economiche, affettive o politiche – avverranno e già avvengono attraverso la mediazione di un sistema digitale. Lo scambio di ieri è oggi e sarà domani soprattutto uno scambio di informazioni, di dati. Questo è, di fatto, il cuore della condizione digitale, della civiltà digitale. Tale semplice operazione rende qualunque operazione che usa un medium tecnologico una operazione a contenuto di valore: valore numerico, valore economico, valore sociale, valore etico e morale. Questo fa presupporre che abbiamo bisogno sempre di più non di meri tecnici, ma di tecnici a valore aggiunto: numerico, economico, sociale, etico e morale. In questa prospettiva desidero portare all’attenzione del lettore e degli operatori, nonché a coloro che hanno in mano le redini della formazione dei nostri giovani, l’opportunità di creare e disegnare tale nuova professionalità e il quadro più generale in cui essa si possa collocare.
Chi è l’antronomo
Stiamo parlando dell’antronomo e dell’antronomia. Il neologismo che abbiamo coniato con alcuni amici ed esperti di settore è di derivazione greca e sta a significare una persona che pone l’umano come norma all’interno di un processo di innovazione e in una condizione digitale. In altri termini è un professionista che attinge da competenze trasversali di vari saperi e scienze e li applica affinché una innovazione tecnologia soprattutto digitale possa essere a servizio dell’umano e delle sue istanze, possa in altri termini essere una innovazione antropica. L’antronomo risponde esattamente alle esigenze e le istanze che la via europea propone e chiede. Insieme all’Equipe dell’Apostolato Digitale e ad alcune università e istituti superiori, stiamo lavorando per calare nel concreto questa intuizione disegnando dei corsi di scuola superiore e di laurea magistrale afferenti a differenti discipline che abbiano al loro interno, oltre alle materie proprie di tali discipline, anche un bagaglio di conoscenze tali per cui al professionista sia data la possibilità di interagire con coloro che più direttamente disegnato e progettano sistemi di intelligenza artificiale o più in generale tecnologie emergenti legate alla trasformazione digitale.
I corsi legati alla figura dell’antronomo debbono conferire agli studenti, oltre alle conoscenze scientifiche necessarie, ad esempio, a essere psicologo o infermiere o architetto, anche quelle conoscenze di base sulla trasformazione digitale indispensabili per dialogare con informatici, aziendalisti, ingegneri, fisici che progettano e realizzano innovazione digitale.
L’antronomia nel suo complesso sarà dunque non propriamente una scienza a sé, ma una visione dei saperi legati all’innovazione capace di tenere insieme saperi e valori, di implementare i valori attraverso specifici saperi non giudicando a valle l’esisto di un processo di innovazione, ma partecipandovi da subito, ponendosi a monte di tale processo e conferendo quelle conoscenze necessarie affinché il prodotto o servizio non sia semplicemente conforme a una normativa o adatto a essere utilizzato da un essere umano o, ancora più semplicemente, funzionale a un determinato scopo produttivo ed economico, ma – rispondendo alla mens della normativa europea – propriamente antropico, capace cioè non solo di non nuocere all’essere umano ma di favorirlo, negli scopi legati a quella determinata tecnologia che si sviluppa, ma anche e più in generale a un ecosistema di tecnologie che incorporando una dimensione valoriale collaborino a fare di quei valori la cultura e la vita delle persone ogni giorno.
Conclusioni
Mettere l’umano al centro, così come spesso si ripete trattando di questi temi, se è chiaro cosa significhi a livello concettuale e valoriale, non è altrettanto evidente cosa comporti nei processi di innovazione. All’antronomo il compito di renderlo effettivo.
Qui per il post originale
Con l’«Apostolato digitale» l’annuncio allarga lo sguardo
Digitale e apostolato stanno insieme? La realtà di quanto stiamo sperimentando ci dice di sì, anzi ci dice che un mondo già smarrito e ulteriormente provato dal Covid cerca la parola della Chiesa proprio nella trasformazione digitale.
In questi mesi noi di «Apostolato digitale» abbiamo portato un contributo a oltre 80 conferenze, dal Consiglio nazionale forense sino alla cattedra Jean Monnet dell’Università di Torino, dalle associazioni di impresa come Assochange alla Milano Digital Week, per concludere in questi giorni con la Ifc Sustainability Exchange organizzata da Banca Mondiale su sostenibilità, inclusione e tecnologia. Abbiamo parlato a più di 5mila giovani alla Smart Future Accademy e animato un corso su tecnologia e religione voluto dagli studenti di alcune scuole superiori del Centro Italia. Ci è stata chiesta una rubrica settimanale in onda su 23 radio locali e interventi regolari sull’Huffington Post. Domani insieme a Fondazione Leonardo per le Macchine nasce «Civiltà digitale», percorso per affrontare questi temi in relazione ai diritti umani e alla democrazia.
Papa Francesco ha intuito questo bisogno: «L’ambiente digitale rappresenta per la Chiesa una sfida su molteplici livelli; è imprescindibile quindi approfondire la conoscenza delle sue dinamiche e la sua portata dal punto di vista antropologico ed etico. Esso richiede non solo di abitarlo e di promuovere le sue potenzialità comunicative in vista dell’annuncio cristiano, ma anche di impregnare di Vangelo le sue culture e le sue dinamiche». Ci pare di poter dire che il digitale è un segno dei tempi, un luogo teologico in cui fare apostolato non è solo usare tecnologie della comunicazione, ma confrontarsi con le tecnologie emergenti nel loro complesso. Non sono più, come le tecnologie del passato, un mero strumento, ma ormai un motore di senso e di significato. La trasformazione digitale può essere motore di giustizia o ingiustizia, di libertà o schiavitù, luogo di trasfigurazione o alto monte su cui cedere alle tentazioni di chi propone salvezza alternativa. Il mondo, ma anche la Chiesa, hanno bisogno a nostro avviso prima di tutto di pensiero, di ascolto dello Spirito che si fa saperi, visioni, soluzioni, direzioni di lavoro. Ne abbiamo bisogno per poter trarre dal nostro tesoro cose nuove assieme a quelle antiche, da trasfondere nella pastorale ordinaria delle comunità e del- le diocesi, ma anche nella cultura e nei paradigmi economico-sociali che governano la realtà.
Per questo a Torino esiste dal 5 novembre 2019 il «Servizio per l’Apostolato digitale»: non un semplice osservatorio, ma uno strumento a servizio della Chiesa e del dialogo Chiesa-mondo. Pregare, discernere, pensare e agire nella trasformazione digitale si declina oggi in diverse strade. Il 4 giugno presentiamo una nuova laurea magistrale in psicologia dell’innovazione digitale dell’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo che genererà una nuova figura professionale, l’antronomo, uno psicologo che affiancherà i matematici e i fisici nella creazione di tecnologia portando l’umano come norma, principio ispiratore del processo creativo e di progettazione. Stiamo dialogando per creare una laurea analoga in Scienze infermieristiche e un corso di studi superiori con uno dei licei più significativi di Torino. Da tre anni ormai abbiamo un corso di Spiritualità delle tecnologie emergenti all’Università statale e collaboriamo con il Politecnico per Biennale Tecnologia.
Apostolato digitale ad intra significa ancora cultura e pensiero con rubriche mensili su Dossier Catechista e Moralia, il blog de Il Regno con l’Associazione teologica italiana per lo studio della morale. E ancora, la collaborazione con Note di Pastorale giovanile, tre corsi di teologia in altrettanti corsi di laurea: Economia alla Cattolica di Milano, Scienze infermieristiche al Cottolengo e Psicologia con Iusto. Il progetto «Pompei Lab» – dal nome della parrocchia Madonna di Pompei a Torino in cui trova casa – tenta di far atterrare tutto questo nella pastorale ordinaria. Un oratorio in cui gli universitari si trovano e dialogano sui temi del digitale, creano codice e si ritrovano per partecipare a competizioni mondiali sull’uso dell’intelligenza artificiale per il bene comune, corsi di alfabetizzazione digitale per le persone anziane, incontri per genitori e adulti per capire il digitale e la sua portata, un post-Cresima in cui i ragazzi imparano a testimoniare la fede facendo pagine di Wikipedia e i più piccoli sostituiscono il vecchio cartellone con la programmazione di robot didattici, guidati dagli studenti del Politecnico. Tutto ciò tentando di essere in ascolto dello Spirito e della Tradizione della Chiesa: è nata per questo una collaborazione con la Fondazione Carlo Acutis che custodisce la memoria del nuovo beato che seppe guardare alle tecnologie con fede autentica. Cosa ci suggerisce il suo carisma nel grembo della Chiesa?
La fede e le domande di fede oggi si confrontano con un modo rivoluzionato dal digitale: le risposte di sempre non devono semplicemente cambiare vestito per adeguarsi a nuovi linguaggi, ma fare i conti con identità formate in un nuovo contesto, con affettività segnate dalla connessione digitale, con attori sociali che si servono del potere computazionale per trasmettere valori lontani dal Vangelo. Lo stiamo raccontando alle comunità, alle associazioni, alle diocesi che ci invitano, in Italia e non solo. Quando papa Francesco ci dice che «l’annuncio alla cultura implica anche un annuncio alle culture professionali, scientifiche e accademiche» ci chiede di provarci, rischiare. «Apostolato digitale» dunque non è il carisma di uno solo, e neppure di un gruppo: è della Chiesa e nella Chiesa, è essere apostoli, non nell’ambiente digitale ma nel mondo che è digitale. Non con il digitale, ma consapevoli che il digitale è parte di noi, del nostro quotidiano, del nostro vivere e sperare, dunque del nostro credere. Un motivo di riflessione anche per il cammino sinodale della Chiesa italiana? La realtà ci suggerisce di sì.
Qui il post originale