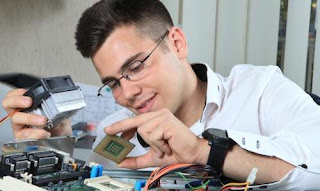Uno dei tratti della condizione digitale è quello di sollecitare il presente a prevedere il più possibile il futuro.
Tale tendenza deriva un po’ dalla necessità di farvi fronte in termini di personale e strutture adeguate, un po’ forse per esorcizzare un futuro «macchinizzato» e non del tutto desiderato dall’essere umano.
Altri motivi certamente possono essere enumerati, quello che ci anima è piuttosto il desiderio di dare vita a qualche possibile profezia, tale per cui il futuro sia il più possibile corrispondente a un’antropologia accettabile e a un’organizzazione della società che rispetti la dignità dell’essere umano e le sue istanze di verità e di trascendenza.
Con queste premesse, in questo e nei prossimi interventi vorrei – insieme ai lettori – fare qualche affondo rispetto ai lavori del futuro, le professioni che secondo il World Economic Forum saranno la «top 10» del 2030 e degli anni successivi.
Naturalmente sono indicazioni, ma provenendo da un soggetto che non solo si applica a pensare, ma è costituito da molti dei poteri che in effetti realizzano il futuro, le indicazioni sono certamente interessanti.
Cominciamo così con il primo tra i lavori futuri, il facilitatore di smart working. In questo ambito la pandemia ha quasi ribaltato le percentuali: siamo passati da un 5% di persone che usava questa modalità di lavoro, a percentuali a due cifre, in questi mesi in continua fluttuazione, ma certamente in ascesa verticale. Per dirla con una battuta, buona parte di coloro che fanno un lavoro di concetto passeranno alla modalità «casa e bottega».
Che cosa questo significhi dal punto di vista giuslavoristico e della programmazione e organizzazione aziendale lo possiamo bene immaginare. Il facilitatore di smart working che cosa dovrà dunque fare? Il ventaglio di azioni possibili è così vasto che dovrà essere meglio focalizzato e così presumibilmente avverrà.
In questa sede uno degli elementi che possono essere suggeriti è una migliore e maggiore educazione alla responsabilità. Il non essere inseriti in un’organizzazione stringente, con dei confini anche fisici che incanalano corpo e mente verso determinati obbiettivi, obbligherà le persone a farsi maggiormente carico di se stesse, dei propri tempi, delle proprie responsabilità. Questa è una buona notizia. Possiamo ricordare, con il Compendio della dottrina sociale della Chiesa (introduzione n. 16), che «Il confine e la relazione tra natura, tecnica e morale sono questioni che interpellano decisamente la responsabilità personale e collettiva in ordine ai comportamenti da tenere rispetto a ciò che l'uomo è, a ciò che può fare e a ciò che deve essere».
Una condizione lavorativa in cui le persone devono – oltre al lavoro considerato in sé e per sé – assumersi maggiori responsabilità verso sé stessi, può rappresentare un buon banco di prova e una buona occasione per ritornare a proporre maggiore educazione e formazione rispetto a questi temi. Il facilitatore di smart working evidentemente dovrà preoccuparsi che il sistema sia efficiente ed efficace, ma nello stesso tempo, proprio per la natura stessa dello smart working, dovrà essere il primo promotore di una cultura aziendale in cui il singolo si senta parte, benché non veda il resto, di un solo corpo, di un unico team.
Questo ulteriore aspetto, legato ai temi della cittadinanza, del bene comune, di quello che in teologia chiamiamo ragionare e vivere a corpo, diventa un’ulteriore interessante frontiera e sfida. La cultura d’impresa, nella metamorfosi digitale, diventa sempre di più un’occasione per far crescere e trasformare la cultura in senso più ampio anche nella direzione auspicata dalla dottrina sociale della Chiesa, una sfida da cogliere insieme.
Con l’aiuto dei facilitatori di smart working, perché no?
Qui il post originale